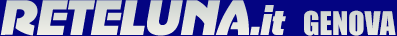 Interventi
Interventi

di Gianluca Valpondi
Nel 40ennale della strage di via Fani, giova ritornare sulla figura di Aldo Moro per scoprirne aspetti piuttosto inaspettati che ce lo facciano conoscere meglio. Stavolta mi piace incrociarlo con un’altra suggestiva ricorrenza: i 50 anni dal 1968. Sappiamo un po^ tutti quanti, seppure dalle più svariate e diverse angolazioni, cosa fu il ‘68, una data che identifica ormai per chiunque quel “movimento giovanile” che arrivò anche in Italia a sconvolgere in buona parte la nostra società, partendo soprattutto dagli ambienti universitari e coinvolgendo o almeno toccando pian piano e in tanti rivoli innumerevoli persone. In meno invece sapranno che lo statista Aldo Moro più di vent’anni prima già era consapevole - e ne scriveva con audace, tenero e severo spirito profetico - della potenzialità, nel bene ma anche nel male, del mondo universitario nel lanciare i giovani verso la trasformazione della società. Di nuovo, mettiamoci all’ascolto, senza fretta.
“L’incontro con l’Università rappresenta la scoperta della vita sociale. Società è certamente la famiglia e, nel suo ambito ristretto, anche la scuola media. Ma quale più largo respiro, quando si varca la soglia dell’Università, quale ricchezza d’incontri e di esperienze! Perché la vita sociale è soprattutto coscienza del vivere insieme, curiosità di sé e dell’altro, interesse, timido prima e poi sempre più vivo, di una integrazione che tolga alla propria piccola vita, chiusa e scura, e riveli più vasti orizzonti di comprensione e di azione comune. Pensate a quella rivelazione di nuovo che è la giovinezza, quel trepido e irresistibile aprir gli occhi alla vita, quel sogno prima vigilato, che vuol confrontarsi mano a mano con la realtà e la inonda di luce. Quanta parte di questa attesa, di questa rivelazione decisiva si risolve nella scoperta dell’uomo, di un altro spirito, nel quale abita un soffio di divino. Questa più vasta realtà, che sollecita l’attenzione e l’amore di coloro che hanno vent’anni, senza un uomo che ne sia al centro, che la capisca, la ami, la faccia sua, pare dissolversi nel nulla come un’illusione cattiva. Una aspirazione multiforme e infinita non si contiene in una sola anima, nella propria anima che par vuota e fredda e incapace di fronte a così grande e dolce lavoro. Non è qui la radice dell’amore che appare in questa età aperta a ogni esperienza come una stupenda promessa di comprensione e di possesso? Non è l’altro il tramite, per la nostra stessa vita, per la nostra vita piena? Così l’Università, che cade nella vita del giovane, quando la coscienza si sveglia e si accende il desiderio di vivere, rappresenta tra gli altri suoi aspetti il primo incontro umano, il primo serio e gioioso a un tempo, problema di convivenza. Perché la vita universitaria è così molteplice e varia, così aperta, così sempre crescente sopra se stessa, così facile, vorrei dire, all’evasione da se stessa, questa esperienza sociale di cui parlavamo non si esaurisce nelle aule e nei cortili dell’ateneo. Per qualcuno l’impiego, imposto dalle necessità di un tempo straordinariamente difficile, è un avviamento contemporaneo, e ben più rude e problematico, a più larghi incontri sociali. Per altri, per tutti forse (ché sottrarsi a questo impulso è cosa tanto difficile e in fondo cattiva) vale piuttosto la insoddisfazione di un ambiente comunque definito, largo, se volete, ma uniforme negli interessi e chiuso in se stesso. Com’è viva di impulsi e di cose nuove e decisive, fuori, la vita! Scoprire un altro uomo, è come iniziare una esperienza senza fine. Per quanto son diversi gli uomini l’uno dall’altro, per quanto variano di contenuto e di capacità a integrare gli incontri umani, per tanto si svolge in una progressione continua la vita sociale dei giovani. Al di là dell’Università c’è la propria città e questa o quella forma associativa; al di là della propria terra una patria mutilata, dolorante e incerta di se stessa; al di là della patria c’è un mondo, sconosciuto il più delle volte, ma che esercita una attrattiva misteriosa, ch’è nostro, perché fatto di uomini della nostra stessa umanità. Gli inviti a uscire dal proprio chiuso, a guardare lontano, a operare largamente non vengono per questi uomini di vent’anni dal di fuori, ché cadrebbero invano, ma dal loro intimo, ma dal loro stesso mondo universitario, così mobile e aperto, così sensibile al complesso della vita. Qualche volta le sollecitazioni sono interessate o goffe e mal riescono a celare il motivo che le determina, ch’è di approfittare della inesperienza e dell’entusiasmo naturale dei giovani, per trascinarli per vie ch’essi altrimenti non percorrerebbero.
Qualche volta ancora prevale quel senso di chiuso da cui deriva un riserbo, un pudore, un timore di darsi e di perdersi, i quali, benché spiegabili e giustificabili, restano tuttavia cose cattive e determinano per i giovani il pericolo di fare molto poco del lungo cammino che sta loro dinanzi. Chi entra nell’Università farà bene a tenersi in guardia contro queste due tentazioni ugualmente distruttive: dalla smania dell’azione e dalla pavida inerzia, dalla superficialità grossolana di un attivismo sempre soddisfatto di sé e dalla rinuncia a vivere, a credere, ad amare. Bisogna che l’universitario sappia che al di là della scuola e in perfetta continuità con essa, c’è la vita, che i suoi compagni si prolungano nei concittadini e nei cittadini del mondo, che la buona amicizia universitaria prosegue naturalmente come una cordiale amicizia con gli uomini noti e ignoti nel vasto mondo. Nel quale si decide, tra paci e guerre, tra prepotenze e intese, del destino degli uomini, del destino di ciascuno di noi. Nel quale si vive compiutamente la vita e si soffre e si spera e si lavora e si fantastica e si crede. E non son queste le cose cui il giovane prenderà parte domani, non sono queste cui egli darà il suo contributo di competenze e di amore? Veramente l’Università è un piccolo mondo nel quale quello grande completamente si riflette. Se volete che l’Università sia una cosa seria, che non sappia di vuoto, di chiuso, di antico, mettetela al ritmo agile, anche se irregolare, della vita. Fate che la vita vi pulsi dentro, che la società con i suoi interrogativi vi si rifletta, che i problemi della difficile convivenza umana vi siano compresi e affrontati. Fate che questa piccola società sia un ponte verso la vita. C’è però un modo di avvicinarsi dall’Università alla vita e, quando sia trascurato, la nuova esperienza è piuttosto distruttiva che costruttiva. Ed è il modo della sincerità, della lealtà, della chiarezza, quell’abito interiore di raccoglimento e di verità ch’è proprio degli altri studi. Il problema è tutto qui: portare nella vita sociale lo spirito dell’Università senza patteggiamenti. E l’allettamento dell’ipocrisia e della resistenza alla durezza con la durezza, alla slealtà con la slealtà è così vivace, che da questo pericolo soprattutto han da guardarsi i giovani. La vita sociale può essere un tramite di pienezza e di elevazione o invece una orribile mortificazione della persona, un livellamento mediocre nel termine più basso. Che sia l’una o l’altra cosa dipende dalla sapienza della vita, quella che il giovane, che sia capace di restar tale e cioè fedele a se stesso, ha in così larga misura. Bisogna, in una parola, sapersi controllare, perché non sia questa esperienza una scorribanda brutale pel mondo, la quale uccida in noi e negli altri quel che v’ha di migliore, ma un aprirsi docile e trepido a nuovi orizzonti, una scoperta rispettosa dell’uomo, un donarsi spigliato alla vita, in una parola, un atto di amore. Questa è una grande responsabilità di quelle che fan diventare uomini”. (A. Moro, su «Ricerca», anno II, n. 1-2, 15 gennaio 1946)
Mi viene subito in mente quando Italo Calvino scrisse al giovane fascista Eugenio Scalfari «per quanto io aspiri a un “modo di salire” e tu a un “salire ad ogni modo”»; e di qui il pensiero va al giovane Manzoni di In morte di Carlo Imbonati, che scriveva «“Sentir”, riprese, “e meditar: di poco / esser contento: da la meta mai / non torcer gli occhi, conservar la mano / pura e la mente: de le umane cose / tanto sperimentar, quanto ti basti / per non curarle: non ti far mai servo: / non far tregua coi vili: il santo Vero / mai non tradir: né proferir mai verbo, / che plauda al vizio, o la virtù derida”». Moro ci parla della vita come atto d’amore, e del sapersi controllare perché il “peace and love” non sia la maschera ipocrita della più brutale sfrenatezza. Il dominio di sé è un frutto di quel “soffio di divino” che ci abilita al dono di noi stessi, perché chi non si possiede non può donarsi, nessuno può dare ciò che non possiede. Ritrovarsi nel darsi, per darsi ancora e ritrovarsi, nell’incontro tra le persone, e le Tre Persone nelle persone nelle Persone... Pace e amore, sì, perché l’unico Dio che esiste è quello della pace e dell’amore.
Giovedì 12 luglio 2018
© Riproduzione riservata
1977 visualizzazioni