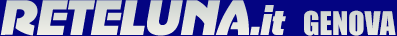

Negli ultimi decenni si è riconosciuta un'importanza strategica primaria alle modalità di coinvolgimento nella attività aziendale di tutto il personale (indicato, appunto, con il termine "Risorse Umane" dalla terminologia inglese "Human Resources"). È fuori dubbio infatti che dal proporsi della popolazione aziendale rispetto al contesto della azienda e verso l'esterno, nonché dalle condizioni di "vita" all'interno della unità produttiva discenda una maggiore o minore resa in termini di produttività e, in definitiva, in termini economici e di bilanci finali. Senza contare che tutta la materia ha anche una rilevanza non meno significativa dal punto di vista delle etiche sociali, alle quali il mondo della produzione sembra essere sempre più attento. In altre parole benessere aziendale e profitti produttivi sono concetti che spesso vanno di pari passo.

Aldo Carpineti
È nato a Genova il 12 ottobre 1949. Dopo la gioventù genovese, liceo Classico e laurea in Giurisprudenza ha fatto del cambiamento un modo di vivere; si è spostato per lunghi periodi nel Veneto e nelle Marche, tre anni a La Spezia, sedici in Toscana, per poi fare ritorno ogni volta alla vegia Zena. Prima sottotenente di vascello in Marina, poi funzionario aziendale nelle relazioni industriali, è stato anche manager di gruppi professionisti di musica classica, barocca, jazz. Ha pubblicato Stanzialità e Transumanze (2003) riflessioni in epigrammi su argomenti di varia natura, Finestre su Paesaggi Miei (2004) due racconti di cui il secondo è un noir, La casa con le vetrate (2006), Un amore Maturo (2012). Fra tutte le cose che fa abitualmente non c’è nulla che gradisca quanto sedersi al tavolino di un caffè o di un ristorante in compagnia della figlia Giulia.
TAGS
Feb 1
di Aldo Carpineti

E’ noto che uno stipendio inferiore alla media, o comunque inadeguato alle reali capacità, disincentiva il lavoratore più di ogni altro motivo. Non è altrettanto vero, o almeno non è sempre vero, che un aumento di stipendio rappresenti il maggiore stimolo ad accrescere l’impegno e la volontà di fare bene. Studi recenti e trascorsi hanno infatti dimostrato che un adeguamento in termini retributivi viene “sentito” dal dipendente, in media, per i successivi due mesi, nei quali le sue forze effettivamente si moltiplicano nella direzione del raggiungimento di risultati migliori, ma poi, passato questo periodo iniziale, il soggetto torna su livelli di resa sostanzialmente comparabili con quelli precedenti.
Posto che il discorso ha un valore di buona approssimazione, non necessariamente riscontrabile caso per caso, si può dire tuttavia senza troppi timori di cadere in errore che le motivazioni che possono migliorare il rendimento delle prestazioni lavorative siano da ricercare altrove.
Non è neanche soltanto un problema da archiviare in termini di “attaccamento” all’azienda ed al proprio lavoro: la “fedeltà” (intesa nel senso di lunga permanenza presso la stessa società) era un elemento molto più premiante e premiato nel passato di quanto lo sia oggi. Lo stesso trattamento di fine rapporto (altrimenti detto “liquidazione”) rappresentava il corollario finale di una storia personale ed offriva, in termini monetari, un riconoscimento assai cospicuo ed ambito, spesso atteso con uno stato d’animo particolare anche dal punto di vista emotivo. Tutti sappiamo che non è più questa, per vari motivi, la realtà dei nostri giorni: l’imprenditore intenzionato a ricercare le soluzioni che siano spinta alla ottimizzazione delle prestazioni dovrà perciò avere attenzione ad altre motivazioni e più intrinseche al soddisfacimento delle esigenze del lavoratore in quanto “persona”.
Usando qui una terminologia molto elementare ma efficace, è stato dimostrato da dottrine lavoristiche che hanno avuto il loro inizio e sviluppo negli anni ’80 e ‘90, come il lavoratore abbia una resa maggiore, soprattutto dal punto di vista qualitativo, se “sta bene” in azienda, se ci vive volentieri, se gli è dato di esprimersi in un ambiente il cui “clima” possa soddisfare le sue esigenze di qualità della vita, dal punto di vista dei rapporti con le persone (segnatamente con i responsabili) e dell’adattabilità ai mezzi strutturali.
Ma oggi anche la figura del
“dipendente” è molto cambiata rispetto al
passato: chi lavora è sempre meno dipendente e sempre
più “imprenditore di se stesso”, sempre
più “soggetto” di quello che compie e realizza.
Il periodo taylorista-fordista, per tradizione caratterizzato dal
lavoro in catena di montaggio, sostanzialmente monotono e
ripetitivo, e da una precisa suddivisione dei compiti ha lasciato
il posto ad una realtà in cui, nell’organizzazione
aziendale, a tutti è richiesto di essere dei tecnici:
l’operaio che lavora alle macchine utensili, tanto per fare
un esempio, dovrà essere in grado di utilizzare strumenti
computerizzati, cosiddetti “a controllo numerico”,
sempre più sofisticati e adatti ad essere maneggiati
soltanto da chi abbia una preparazione specifica;
l’impiegato, il quadro, il dirigente, sono portati, sempre di
più, a cercare soddisfazione personale e professionale
muovendosi da un’azienda ad un’altra in modo da
accrescere e diversificare le proprie competenze e salire, in
questo modo, i gradini della propria carriera. Sono molti oggi a
pensare che il lavoratore tanto più si sentirà
appagato dalla vita in azienda quanto maggiormente troverà
in essa un ambiente adatto per “realizzare” se stesso:
e se il datore di lavoro gli saprà fornire le condizioni
più idonee a questo scopo ne farà probabilmente una
persona potenzialmente orientata verso le migliori prestazioni.
Perché tutto ciò possa avvenire ha certamente la sua
importanza quello che veniva definito come “clima”, in
altre parole l’atmosfera che si respira fra le quattro mura
aziendali, derivante soprattutto dalle cosiddette “relazioni
interne” (altro concetto che, a buon titolo, ha avuto grande
fortuna nella storia delle teorie del “personale”
applicate al mondo aziendale). Ma oggi si ritiene che il lavoratore
chieda qualcosa di più di un ambiente disposto ad
accoglierlo confortevolmente e dove i rapporti umani siano
sintonici.
In passato veniva presentata come una virtù quella di chi si sapeva accontentare della propria condizione. Sono poche, invece, ai nostri giorni, le persone nelle quali non si noti una volontà di migliorare, in un modo o nell’altro, la propria condizione personale, soggettiva e sociale: al tempo stesso si sta verificando, confortato da tendenze in tal senso nei mondi della filosofia, della sociologia e della psicologia, dai quali è lecito ed opportuno attingere, un recupero degli aspetti “individuali” della persona, nella considerazione che la valorizzazione di essi conduce all’utilizzo delle migliori capacità specifiche di ognuno, con soddisfazione generale: se da una parte si riconosce che certi traguardi sociali si raggiungono soltanto unendo le forze e potenziando il collettivo, dall’altra tendono ad essere valorizzate le peculiarità, le attitudini e le conoscenze personali, così da avere risposte utili sempre più diversificate ed originali.
In questo senso, e nella maggiore misura possibile, l’azienda potrà trarre beneficio dall’apporto di ognuno, quanto più ai soggetti sarà dato di esprimersi secondo il raggio di tutte le skills di cui dispongono. Non soltanto nei termini di attitudini al proprio lavoro, ma anche in quelli di incoraggiata disponibilità a ruoli propositivi per la vicenda aziendale. Ed ancor più nell’assunzione da parte del lavoratore dell’abitudine a pensare che il mondo dell’azienda dove lavora abbia un senso determinante nella “riuscita” della propria esistenza.
E’ anche un elementare principio che risponde a criteri di economicità, in una situazione di contingenze nelle quali, per necessaria scelta, ogni organizzazione deve badare strettamente alle spese, “sfruttare” (anche se può suonare poco opportuno usare questo termine) tutto quanto di meglio ogni voce, contabilmente attiva o passiva, può rendere. Non c’è dubbio che questa soluzione possa rappresentare anche un risparmio economico dal punto di vista del contenimento degli organici e dei relativi costi. Lo si voglia o no, il personale rappresenta un capitolo di “spesa” a bilancio, quasi sempre fra i più consistenti. Ed è legittimo aspettarsi che ad ogni “costo” corrisponda una contropartita adeguata. Al tempo stesso predisporre e congegnare la realtà in modo da dare l’opportunità ad ognuno di “venir fuori” potrà offrire ai soggetti le maggiori probabilità di trovare soddisfazione personale attraverso l’espressione, la messa a frutto, anche a proprio beneficio, di tutto quanto di cui dispongono in termini di capacità e versatilità proprie; soprattutto se il datore di lavoro avrà saputo vincere le sue ritrosie legate a volte alla pretesa posizione di unico determinatore dei destini dell’azienda.
Certamente le condizioni dovranno essere tali da far sì che il dipendente non debba sentirsi “spremuto” ma, al contrario, realmente “valorizzato”. Sarà dunque quasi un’“arte” per l’imprenditore e per i suoi collaboratori più immediati impiegare il dipendente secondo i criteri più remunerativi procurandogli al tempo stesso il massimo di soddisfazione dal proprio lavoro.
Né va sottovalutato che una simile interpretazione bilateralmente coincidente fra gli interessi in gioco richieda un particolare atteggiamento psicologico da parte del dipendente, oltre che del datore di lavoro.
“Occorre, dunque, sviluppare un ambiente, un clima, una cultura d’interesse e valorizzazione dell’apprendimento continuo e della crescita delle competenze che possa indirizzare sistematicamente le persone verso il proprio sviluppo professionale” (Marco Rotondi: Work Learning Place: un modello di formazione centrato sulla fiducia).
“E’ oggi possibile, se si vuole, scegliere una strategia specifica di know-ledge management che abbia lo stile inconfondibile del rispetto della persona che apprende e della valorizzazione delle competenze individuali e collettive” (Alberto Munari: Processi d’apprendimento e gestione del know-ledge nelle organizzazioni)
“Da molte ricerche emerge con forza il dato delle culture ‘espressive’, di quelle culture del lavoro, cioè, che assegnano a quest’ultimo la funzione dell’opportunità. Secondo questa cultura ‘il lavoro è la possibilità di costruire insieme un progetto personale e professionale, da soli o con altri’. Dove convivono nella complessità la dimensione della persona e quella professionale, sempre più intrecciate tra loro e non più divise; la dimensione del lavoro come progetto e non solo come diritto, ciò che apre ad un mondo nuovo; e, infine, la dimensione individuale e soggettiva ma anche quella sociale e collettiva” (Walter Passerini: Le parole per dirlo: la ricerca del senso nelle organizzazioni).
Soprattutto da questo ultimo intervento di Passerini emerge come il lavoro, invece che un semplice mezzo utile per far fronte alle proprie esigenze economiche e di sopravvivenza, possa arrivare ad essere uno dei canali a disposizione per la realizzazione della propria vita, anche sotto il profilo eminentemente “esistenziale”, attraverso la caduta di quelle barriere che di fatto impediscono la “fusione” tra gli interessi personali e privati del soggetto con quelli lavorativi e, in definitiva, attraverso l’abbandono del concetto secondo il quale vita privata e lavoro siano due momenti diversamente ed indipendentemente definiti. Tutto ciò non procurando ingerenze dell’azienda nel privato, ma piuttosto con l’assunzione del punto di vista, da parte dal soggetto lavoratore, di una considerazione complessiva ed unitaria della propria vita, pur nella complessità e molteplicità degli interessi e delle aspirazioni.
Se la “passione” per il proprio lavoro era un tempo frequente appannaggio delle sole professioni, utili al soggetto anche sotto il profilo della gratificazione personale, è necessario oggi che queste benefiche attribuzioni vengano a far parte di ogni attività lavorativa.
Per la realizzazione di queste basi e di queste premesse, rimane preminente la funzione del mezzo formativo che è sempre fra i più validi a stimolare il verificarsi delle condizioni cui si tende: il dipendente dovrà poter ricevere il messaggio che l’azienda rappresenta un mondo culturalmente propositivo, di sviluppo della propria personalità, del proprio stesso “io”. In questo senso deve giocare altresì il superamento di tanti baluardi che per tradizione si oppongono, da una parte e dall’altra, a far sì che quello del lavoratore sia sempre meno “lavoro dipendente” e sempre più “collaborazione”, come è intrinseco nel concetto di lavoratore come “imprenditore di se stesso”. Anche il dipendente, in altre parole, è destinato e deve diventare sempre più “professionista”.
Purtroppo varie spinte si oppongono ancora a questa tendenza: da una parte la volontà di essere gli unici a determinare le scelte e i destini della propria azienda, concepita come qualcosa su cui si ha un “diritto di proprietà” assoluto (il classico atteggiamento padronale, non ancora estinto soprattutto nelle aziende di piccole dimensioni, del “qui si fa come dico io”), dall’altra la riluttanza ad avvicinarsi alle posizioni proprie della guida aziendale, conseguenza di timori, non sempre fondati, di esserne assorbiti.
E’ evidente come alle organizzazioni sindacali di parte imprenditoriale e di parte lavorativa che hanno voce a livello nazionale sia demandato un delicato ma fermo ruolo di impulso e di educazione, ciascuna per i propri rappresentati, in questa direzione, in primo luogo attraverso il loro diretto atteggiamento ed esempio.
© Riproduzione riservata
1094 visualizzazioni